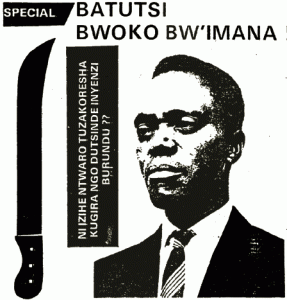AL CUORE DEL PROBLEMA: UNA FARSA CHIAMATA ETNIA E IL DEFAULT DELL’INFORMAZIONE
di Manlio Masucci
E’ stato il principale slogan di politici, commentatori e guru del settore, ripetuto a pappagallo dai principali organi di informazione internazionali: “Si tratta di una lotta tribale, un problema etnico, tutto africano”. Una formula semplice per chi doveva spiegare, accattivante per chi pretendeva quella minima dose di informazione quotidiana, appena sufficiente per potersi sentire cittadino del mondo.
Purtroppo quel jingle martellante, ripetuto ossessivamente anche dai principali media italiani, non aveva solo la caratteristica di esser privo di fondamento, ma quanto piuttosto di esser ipocrita al punto giusto da pregiudicare la comprensione e quindi la possibilità di intervenire per fermare i massacri. Insomma una vera overdose di informazione “tagliata male” che ha fatto perfettamente il gioco dei poteri che si scontravano nello scacchiere delle mille colline ruandesi contribuendo, non poco, al risultato finale di un milione di morti.
Il fenomeno dell’etnicizzazione del conflitto ruandese, che era in realtà primariamente politico e sociale, svela una delle facce più cruente della lotta per il potere in atto nell’Africa post coloniale. Il tribalismo, secondo Jean-Loup Amselle, direttore della scuola delle scienze sociali di Parigi, “è sempre il segno di un’altra cosa, il mascheramento di conflitti di ordine sociale, politico ed economico. Quest’analisi è una di quelle da considerarsi acquisite dall’antropologia e ci si auspicherebbe di vederla ripresa e diffusa nell’insegnamento e dai mezzi di comunicazione di massa”.
Una posizione che chiama in causa l’Occidente e l’imposizione della sua visione e dei suoi valori al resto del mondo secondo la vecchia formula conflittuale del the west and the rest. Proprio Amselle, negli anni ’80, cura la pubblicazione, insieme allo storico congolese Elikia M’Bokolo, di un testo che, con non meno di due decenni di ritardo, è finalmente dato alle stampe anche in Italia. “L’invenzione dell’etnia”, edito da Meltemi, è un lavoro collettivo che affronta, alle radici, proprio la genesi delle interpretazioni distorte e strumentali che l’Occidente ha voluto dare e darsi a proposito delle società africane.
Rileggendo oggi quel testo, è interessante notare come Amselle inizia il suo discorso con un grido di protesta capace di risuonare drammaticamente attuale: “All’inizio degli anni ’80 eravamo non pochi ad averne abbastanza della vulgata giornalistica che consisteva, e consiste tutt’oggi nel rendere conto di un qualsiasi avvenimento che accade sul suolo africano in termini di conflitto tribale o di lotta etnica, rinviando a una sorta di ferocia essenziale che si sarebbe interrotta solamente durante un breve periodo, quello della colonizzazione europea. In effetti, se nell’immaginario giornalistico il mondo arabo è il dominio dell’integralismo e l’India quello delle caste, il continente africano è per eccellenza la terra di elezione degli antagonismi etnici”.
Ma la rappresentazione distorta della realtà africana che offre il giornalismo non è che un sintomo di un male più profondo e radicato che ha le sue radici nell’epopea coloniale occidentale dove le teorie legate all’etnia e la manipolazione dei sentimenti etnici divenivano un instrumentum regni imprescindibile per il controllo del potere. Un’operazione basata su studi antropologici, prevalentemente di carattere evoluzionista, elaborati ed esposti da occidentali ad uso e consumo dell’Occidente, ma che intendevano avere il loro impatto sulle popolazioni autoctone che trovavano nuove chiavi interpretative per la loro stessa esistenza, così come spiega ancora Amselle: “Secondo questa prospettiva, il modo in cui gli indigeni si percepiscono sarebbe legato agli effetti di ritorno dei racconti delle esplorazioni e della conquista ma anche dei testi etnologici coloniali e postcoloniali sulla coscienza di sé”.
Insomma, la visione e l’interpretazione occidentale dell’africanità si configura non solo come distorta ma anche e soprattutto come coercitiva nei confronti delle stesse popolazioni locali. La questione etnica diviene dunque un perfetto strumento nelle mani del potere per dissimulare la sua stessa natura e raggiungere i propri obiettivi. Il colonizzatore estrapola e rafforza identità etniche presenti a livello marginale nella eterogenea società africana che, in un secondo momento, verranno rivendicate dalle stesse popolazioni come “strumento ideologico di determinazione sociale”, nella definizione dello stesso Amselle. Il passaggio dallo Stato coloniale a quello postcoloniale avviene, dunque, nel segno della continuità, nonostante il cambio degli amministratori, e perpetua la visione occidentale di una società africana divisa in non meglio identificate etnie o tribù. Una visione che non tarda a produrre contraddizioni e tragiche conseguenze.
Strano caso quello del Rwanda composto, teoricamente, da due etnie, gli Hutu e i Tutsi, che parlano la stessa lingua, hanno la stessa cultura, hanno la stessa storia e condividono, dalla notte dei tempi, lo stesso spazio geografico. Un caso da manuale, senz’altro, in considerazione della forte radicazione di una coscienza etnica laddove di etnie era veramente difficile poter parlare. Tanto che i belgi dovettero far ricorso a strumenti di misurazione fisici e all’introduzione di carte di identità etniche per poter dare un minimo di solidità a un teorema del tutto strampalato.
Per poter spiegare quello che Jean-Pierre Chretien definisce, in un saggio contenuto nello stesso volume di Amselle, “la cristallizzazione delle coscienze etniche” in Rwanda bisogna risalire alle esplorazioni di metà 800 quando i primi antropologi forgiarono ardite teorie, dai loro comodi salotti londinesi, basandosi sui resoconti di avventurosi esploratori. Legende, approssimazioni, idealismi, implicazioni razziste e suggestioni di stampo letterario e religioso davano a queste analisi un aspetto più pittoresco che scientifico. Basti pensare che l’invenzione della discendenza etiope dei Tutsi ruandesi, inventata di sana pianta dall’esploratore britannico John Speke nella seconda metà dell’800, sopravvisse fino al genocidio del 1994 quando i cadaveri venivano preferibilmente gettati nei fiumi affinché le acque li riportassero al nord, in Etiopia appunto, la terra della loro presunta provenienza.
Una teoria, quella dell’origine etiopica, che era stata, d’altra parte, apprezzata, accettata e rielaborata dagli stessi Tutsi, ben felici di una ascendenza di sì nobili origini. I lunghi drappi bianchi di vestiario e le pettinature sviluppate in altezza delle donne entrarono di prepotenza nella tradizione ruandese proprio per offrire a tutti visibile prova di tale prezioso lignaggio.
Gli allevatori Tutsi, con i loro modi gentili e le loro origini nobili, si presentarono, d’altra parte, come i migliori amministratori del potere coloniale a scapito degli umili Hutu, dediti soprattutto all’agricoltura. I Tutsi rappresentavano anche, agli occhi dei colonizzatori e in perfetta sintonia con le imperanti teorie evoluzionistiche, la traduzione perfetta dell’elite aristocratica e guerriera, immagine speculare del sistema del potere occidentale. In questo bizzarro gioco di ruolo, agli Hutu non restò altro che issare il vessillo del terzo Stato e, in seguito, del proletariato.
I processi di etnicizzazione, creati artificialmente dagli Stati occidentali per mantenere il controllo delle popolazioni assoggettate, esplosero con tutto il loro bagaglio di contraddizioni proprio con l’avvio della decolonizzazione. Alla vigilia della rivoluzione Hutu del 1959, il quadro era completo: il dominatore straniero Tutsi aveva soggiogato e sfruttato per secoli i lavoratori Hutu, una maggioranza silente e ora arrabbiata. Il manifesto Hutu del 1957, che affronta il “problema razziale” in Rwanda e l’avvio dei primi massacri di Tutsi già nel 1959, preludono a uno scenario che si sarebbe rivelato, nel proseguo del tempo, sempre più drammatico. Un’onda inarrestabile di violenze, avvenute sotto l’ala vigile e protettrice degli ex colonizzatori, che portò direttamente, attraverso un viatico di violenza e terrore, al genocidio del 1994, il delitto perfetto, il capolavoro finale di tutta l’epopea colonialista e razzista dell’Occidente.
Aggiungi un commento maggio 8th, 2009